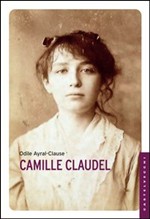 Camille Claudel grazie al padre può frequentare a Parigi (1881) l’Accademia Colarossi, l’unica aperta anche alle donne e nel 1882 affittare con amiche inglesi un Atelier, dove lo scultore Boucher dà loro lezioni, finché non subentra Rodin. Il padre dimostra, nonostante le tensioni con la moglie bigotta, apertura mentale permettendo che a vent’anni andasse – come modella e sbozzatrice, prima donna tra gli allievi – nell’atelier di Rodin con cui avrà una intensa relazione sentimentale. Poi la sofferenza per la rottura con il maestro, la creazione artistica, infine l’internamento in manicomio, deciso dalla famiglia, per trent’anni fino alla morte (1943).
Camille Claudel grazie al padre può frequentare a Parigi (1881) l’Accademia Colarossi, l’unica aperta anche alle donne e nel 1882 affittare con amiche inglesi un Atelier, dove lo scultore Boucher dà loro lezioni, finché non subentra Rodin. Il padre dimostra, nonostante le tensioni con la moglie bigotta, apertura mentale permettendo che a vent’anni andasse – come modella e sbozzatrice, prima donna tra gli allievi – nell’atelier di Rodin con cui avrà una intensa relazione sentimentale. Poi la sofferenza per la rottura con il maestro, la creazione artistica, infine l’internamento in manicomio, deciso dalla famiglia, per trent’anni fino alla morte (1943).
Odyle Ayral-Clause recepisce gli ultimi studi e i dossier medici pubblicati in Francia relativi alla scultrice: se per Arnoux viene sacrificata dalla madre e dalla sorella, e Morel elabora un atto d’accusa contro il fratello Paul, Ayral-Clause sembra più propensa a mitigare le responsabilità di Paul come condividendo le ragioni del ricovero pur senza accettarne le modalità. È vero che alla fine sottolinea gli attacchi d’ira del fratello, simili a quelli di Camille, ma senza le stesse conseguenze giudiziarie e mediche, tuttavia vede Paul come incapace di gestire le tensioni familiari e pieno di rimorsi (ma direi che li supera bene facendo dire, ad esempio, molte messe in suffragio alla morte della sorella). È difficile, a mio parere, trovare giustificazioni se solo si pensa alla campagna di stampa che si scatena quando “L’Avenire de l’Aisne” nel settembre 1913 denuncia la reclusione di Camille e la legge che la permette: l’editoriale cita alcuni brani di lettere di Camille sottolineando quanto sia semplice far rinchiudere qualcuno in manicomio, come è successo alla grande artista, un vero omicidio. Ma la situazione non si sblocca e Paul non si ricrede sull’ingiustizia inflitta alla sorella.
L’autrice insiste sulle “idee deliranti” di Camille e sul suo comportamento antisociale, pur criticando sia l’isolamento cui viene sottoposta (non può ricevere visite né spedire posta) sia il rifiuto della madre anche quando dei medici cercheranno di convincerla a riprendere la figlia. Comunque le sue cosiddette stranezze vanno a mio avviso inquadrate nella difficoltà di lavorare in quanto donna, nella stanchezza e nella solitudine, mentre avrebbe avuto bisogno di un sostegno economico e affettivo. Camille era un’innovatrice nella scultura, ma il suo affacciarsi in questa arte – fino allora esclusivamente riservata agli uomini – ebbe dei costi alti di sofferenza. Vi sono “donne testarde che scelgono di sacrificare tutto pur di dipingere o scolpire. – scrive Simone De Beauvoir – ma esse spendono molte forze in questa lotta, molte forze per fronteggiare l’opinione pubblica e per vincere le intime resistenze degli altri”.
In effetti Camille, anche se apprezzata, trova difficoltà proprio nelle commesse e nelle esposizioni, quindi ha problemi a sostenere le spese ingenti per i materiali e per gli operai necessari alla fusione. Il padre, in una lettera a Paul, si dimostra preoccupato per la figlia, che ha dovuto impegnare alcune sue opere, perché la madre non vuole occuparsene, e lui, sentendo il peso dei suoi 85 anni, non riesce a fare di più per la sua Cam. Nel 1907 Camille, “allo stremo delle forze”, spiega al fratello di non aprire il suo atelier perché si sente usata e copiata, mentre Rodin è osannato: “Mi trovo nella situazione di un cavolo che viene divorato dai bruchi, man mano che tiro fuori una foglia, me la mangiano”. Sembra naturale – sottolinea – che “io debba sopportare tutto, malattie, mancanza di soldi e di qualsiasi affetto”. Dalle lettere all’amica inglese Florence emerge un quotidiano faticoso per Camille, che non può allontanarsi anche se è caldo quando sta preparando una scultura: lavora dalle 7 alle 19, per poi crollare sfinita sul letto. Un tale ritmo – nell’amarezza della fine di un’ipotesi di vita in comune con Rodin – contribuisce ad amplificare i problemi psicologici.
L’autrice ricorda l’organizzazione del manicomio ottocentesco, che si configurava anche come un ricettacolo per quelle patologie in cui l’elemento comune risultava essere l’alterazione del comportamento, cioè una modalità di vivere diversa dalle norme convenzionali della società. E Camille con la sua vita libera e stravagante (”Mi si rimprovera, oh, crimine spaventoso! – scrive a Paul – di aver vissuto sola, di trascorrere la mia vita con i gatti, di avere manie di persecuzione”) appariva inquietante per l’ordine stabilito ed i suoi codici. Narrarsi attraverso la scultura, per Camille significa diventare temeraria, impudica, esponendo sé ed i suoi nudi al giudizio ed all’immaginario in particolare maschile: non rispetta alcuna prudenza emotiva né nella vita né nell’arte, perciò è sepolta viva.
La religiosissima famiglia Claudel, chiusa nel suo moralismo, decide dunque che, nell’interesse di Paul, diplomatico e scrittore, e del cognato, magistrato, una eccentrica come Camille non può più creare scandalo. Con la morte del padre, che aveva continuato a sostenerla, fu facile ad una madre e ad una sorella che non l’amavano, farla rinchiudere in manicomio (marzo 1913) e lì lasciarla morire, senza contatti: il fratello – che pure da giovane adorava con vibrazioni morbose Camille – mi sembra ormai preso dalla carriera e dalla religione, difendendosi così forse da quella attrazione e da quella genialità che sembra sconfinare nella follia. Nei suoi diari affermerà: ”Il genio si paga…preghiamo per lei”, facendo sua la correlazione fra genio e follia, pregnante in tanti testi scientifici e letterari ‘800/900, ma aggiungendo che “il peso del genio è pesante a portarsi per una donna!”.
Se l’autrice insiste sulla instabilità mentale di Camille, credo si possa dire piuttosto che – sulla scia di condizioni di vita dolorose, la condanna della madre per essere diventata la “concubina” del maestro, il dolore per Rodin, la difficoltà ad essere apprezzata – si creano per Camille situazioni psicologiche ed esistenziali che hanno forse facilitato l’insorgenza di comportamenti destituiti di senso. E tuttavia le sue lettere – imploranti, rassegnate, arrabbiate, dolenti, ironiche, da cui trapelano la coscienza dell’ingiustizia e la ricchezza di risorse interiori – sono lucide e testimoniano una malattia “discontinua e fluttuante”: non tanto quindi l’angoscia psicotica, ma “la separazione così radicale e così umanamente insostenibile da ogni relazione e da ogni speranza” (Borgna), in una condizione di vita manicomiale, blocca le fragili risorse creative di Camille (nel manicomio non scolpirà più), senza tuttavia spegnerne le emozioni.
È invece condivisibile l’accento messo dall’autrice sul concetto di sfida: “Nessun’altra donna del diciannovesimo secolo osò sfidare apertamente i limiti imposti alla sua libertà d’espressione” come lei, perché “tutto quello che ha fatto è stato un atto di sfida contro i pregiudizi della società in cui viveva”, dalla scelta del lavoro alla determinazione a scolpire il nudo con la stessa libertà dei colleghi maschi, permettendosi di esprimere la sessualità femminile, alla sua insistenza nel chiedere allo Stato delle commissioni. Come scriveva la pittrice Marie Bashkirtseff nel 1880, quasi una profezia, nota Ayral-Clause: “la donna che si emancipa…viene praticamente messa al bando, diventa strana, additata, considerata pazza”. Forse non è un caso che la committenza statale alla fine accettò solo una sua scultura, che rappresentava una donna sconfitta e implorante. Ma Camille aveva trasposto il suo dolore per la fine del legame con Rodin proprio nel gruppo “L’Age mur” (1899) con la giovane nuda, inginocchiata e le braccia tese verso l’uomo che si allontana, avvolto da una figura di vecchia (la morte, ovvero la moglie del maestro). La donna, poi scultura isolata, diventa l’Implorante, dismisura del dolore, ma nello stesso tempo, quel corpo e quel volto intriso di dolcezza ferita sembrano ora rivolgersi ad interrogare il silenzio di Rodin, il silenzio della madre, dei familiari e di quanti hanno potuto condannare la diversa all’universo concentrazionario del manicomio, sancire la sua segregazione in base ai propri fantasmi, al proprio moralismo, con la violenza di chi si arroga il diritto di negare l’esistenza dell’Altra.
Odile Ayral-Clause, Camille Claudel, Castelvecchi 2013, pp. 327, ill., euro 22,00
Simone de Beauvoir, La donna e la creatività, Mimesis/Eterotopia 2001
Danielle Arnoux, Camille Claudel, l’ironique sacrifice, Epel 2006
Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel, Maisonneuve & Larose 1987
Jean Paul Morel, Camille Claudel,une mise au tombeau, Les impressions nouvelles 2009
Eugenio Borgna, Come in uno specchio oscuramente, Feltrinelli 2007
Clotilde Barbarulli, “Camille Claudel, del sogno che fu la mia vita, questo è l’incubo…”, Corrispondersi, a cura di C. Barbarulli e M. Farnetti, Nuova Prosa 49,2008.
PUOI SEGUIRE LA SIL SU:
PASSAPAROLA:
