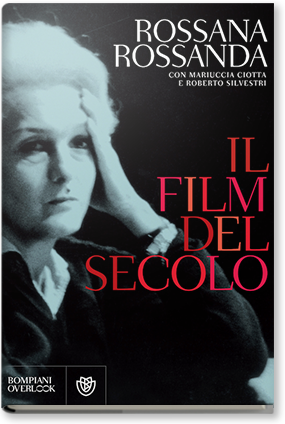 Da “ragazza i film erano la finestra su un pezzo di mondo”, racconta Rossanda che – “a metà strada tra due guerre” – andava al cinema con la mamma e la sorella, “impazienti”, e poi sognerà di essere Ava Gardner (“non Marilyn, come avrei fatto la politica?”). Ciotta e Silvestri 25 anni dopo si ritrovano “un supermercato culturale a disposizione”: “Voi spuntate quando la cultura mondiale è, sì, divisa, ma tutta accessibile, e in Italia la censura è finita. Io vengo da prima della guerra, da quando il fascismo vietava tutto e cercavo di intravedere l’Europa da tutte le fessure possibili”: una diversa formazione per una generazione che “si formò contro”, e, spiega, “non si eredita di colpo tutto quello che è venuto prima”.
Da “ragazza i film erano la finestra su un pezzo di mondo”, racconta Rossanda che – “a metà strada tra due guerre” – andava al cinema con la mamma e la sorella, “impazienti”, e poi sognerà di essere Ava Gardner (“non Marilyn, come avrei fatto la politica?”). Ciotta e Silvestri 25 anni dopo si ritrovano “un supermercato culturale a disposizione”: “Voi spuntate quando la cultura mondiale è, sì, divisa, ma tutta accessibile, e in Italia la censura è finita. Io vengo da prima della guerra, da quando il fascismo vietava tutto e cercavo di intravedere l’Europa da tutte le fessure possibili”: una diversa formazione per una generazione che “si formò contro”, e, spiega, “non si eredita di colpo tutto quello che è venuto prima”.
Dunque non è una memoria intimistica ma legata al percorso politico culturale nel lavoro comune al Manifesto che – nato nel 1971 come “quotidiano comunista” – è stato un tentativo di rivoluzione anche nelle relazioni fra redattori “senza differenza di salari, tutti impegnati tra collettivo e individuale”. Se Silvestri e Ciotta spiegano di essere partiti dalla convinzione dei legami fra cinema, pulsioni profonde e desideri della politica, inaugurando letture svincolate dal mercato, Rossanda sottolinea che il cinema non poteva non essere introdotto nel giornale, perché non si può separare “un progetto dalla cultura da cui deriva o che si vuole modificare”. Ciotta rivela a una Rossanda stupita – impegnata fin da sempre a “far riflettere sul comunismo tentato e da tentare, mentre tutto si andava liquefacendo” – che al giornale era chiamata dai giovani “la nostra diva” in quanto catalizzatrice “di conoscenza, memoria, fascino, che spinge le persone a seguirne l’esempio”.
È un libro a tre dunque che non elude affetti e scontri dopo quarant’anni di lavoro ravvicinato e fa vedere come soggetti diversi, ma operanti nell’ambito della sinistra del Manifesto, si relazionano nel giudicare alcuni eventi filmici; è un “viaggio lungo i cento anni del lungometraggio” che aiuta a ricomporre fili spezzati di questi “militanti dell’impossibile”, a reindagare certi passaggi storico-politici. Dal libro emergono sia la “nostra esagerata simpatia per i film sovversivi”, nota Silvestri, sia “l’idiosincrasia di Rossanda per ciò che è sovversivo e non rivoluzionario”, insieme con appassionate discussioni sull’artisticità e politicità del cinema, sul divismo, sull’industria culturale, da Pasolini a Zhang Yimou, da Leni Riefenstahl al neorealismo.
La memoria fra individuale e collettivo si amplia, si dirama e si articola nell’incontro/scontro, così il giudizio filmico riannoda politica e storia fra sguardi “convergenti e divergenti”, ma è solo se queste diverse esperienze s’intrecciano e si accolgono che può esserci, sostiene Ciotta, un futuro. Se Rossanda – la cui storia politica illumina una parte importante del partito comunista e del Novecento – è stata la prima a scrivere di cinema sul Manifesto con una recensione a Sussurri e grida nel 1973, considerando il cinema uno strumento di propaganda che con la tv contribuisce a rafforzare l’ideologia dominante, Ciotta e Silvestri riflettono su come nell’arco di qualche decennio il cinema ha reso possibile una modificazione del pensiero, discutendo il ruolo della cultura popolare spesso vista come una forma di resistenza al potere costituito.
Per Ciotta il Manifesto ha trattato il cinema con la stessa autorevolezza delle lotte operaie, ma Rossanda problematizza: ”La politica decide sulle vite e, con la fame e la guerra, sulle morti; e non è il caso del cinema. Ma perché metterla in termini di competizione? La politica non è tutto. Neanche il cinema. I piani dell’esperienza sono molti”. Si parla così del sociale-storico attraverso i diversi percorsi. Rossanda – il cui punto di riferimento è dal 1948 il dialogo con gli operai (lo ha ricordato proprio nei giorni scorsi Castellina sul Manifesto pur sottolineando i suoi poliedrici interessi) – si è dedicata alla cultura sentendosi isolata nel PCI perché voleva “che non si dessero più direttive di partito sulla produzione artistica”.
Mentre Ciotta e Silvestri mostrando attenzione anche per i film commerciali di successo ritengono Guerre stellari – che apre “il filone fantascientifico postindustriale” – una “metafora della rivoluzione permanente necessaria” (e su questo non troveranno mai un accordo), Rossanda tiene a sottolineare che l’immagine non conta più della scrittura. Il cinema somiglia alle cattedrali con le statue che “erano la Bibbia di chi non sapeva leggere” ma dietro al significato “che salta agli occhi ce n’è anche un altro” o altri: se talvolta lo svago aiuta a vivere, non lo si può confondere con ciò che fa riflettere e può cambiare l’ordine delle idee, sia un film sia un libro.
L’immaginario può essere più forte della parola, ma Rossanda non si sente sedotta dall’immagine virtuale, è contraria ai “minimalismi passepartout” e ritiene che la parola “è quella che più è riuscita a scatenare l’immaginazione, a costruire un simbolico, a modificare fin l’uso della ragione e dell’irrazionale”. Proprio però per l’impatto dell’immagine filmica, che tocca elementi profondi, occorre criticità: ”Per noi comunisti, il cinema americano degli anni cinquanta, per esempio, non era asettico: predicava la pace sociale, inzuccherava i rapporti interpersonali, e portava sempre la donna in cucina”.
Nel’introduzione Rossanda mette in chiaro che il punto nodale della loro conversazione è collegato a quei paradigmi politici che sopravvalutano la funzione dell’immaginario rispetto alla materialità della lotta di classe: “È impossibile per me, impenitente marxista e comunista… rinunciare all’idea che …è il ‘materiale reale’ che condiziona una società (e la sua ideologia) mentre essi sono convinti che questa sia una funzione soprattutto dell’immaginario collettivo”. Il simbolico, incalza, è una proiezione del reale, ci vuole una civiltà per costruire un simbolico, mentre l’immaginario ci abita tutti, ci lusinga. Il cinema è un’arte che va diretta alle sensazioni, perciò talvolta impatta in modo pericoloso sull’immaginario, ma Ciotta e Silvestri trovano sempre il cinema liberatorio perfino Bollywood.
Anche la produzione americana corrente degli anni cinquanta mostra eroine emancipate tuttavia, nota Rossanda, sottoposte a un tradizionale codice familiare sessuale: perfino le trasgressioni della “deliziosa” Katharine Hepburn stanno dentro i suoi confini. Non c’è mai un riferimento all’analisi della funzione delle protagoniste femminili che percorre la teoria cinematografica femminista, ma Ciotta adora le bellissime cattive coltivate dal cinema, e vede nel noir degli anni quaranta con le sue fatali attrici una trasgressione mentre Rossanda valuta il cinema “maschio, misogino, perpetuo von Stemberg di fronte a Marlene. Le rare Thelma e Louise si liberano per pochi giorni … ma finiranno spiaccicate nel gran Canyon”. Le figure di dark ladies e femmine folli non sono mai sfuggite a una fine tragica, anzi sono state immaginate “per essere messe a morte” e dunque – si chiede – come possono essere considerate indizi di una reale emancipazione dell’immaginario femminile dagli stereotipi maschili dominanti? Direi che è come nel melodramma: alle donne, regine incontrastate della scena, spettano la musica migliore ed i riflettori, ma sempre a loro “il gesto della caduta”: muoiono anche le ribelli, come Tosca, muore Carmen, la più libera (Clement). E tuttavia anche in quei linguaggi narrativi e in quei parametri intellettuali si possono celare crepe dissonanti della rappresentazione codificata. Il fatto è che il cinema, come l’opera lirica, è, tra finzione e seduzione, luogo della magia, dove le figure del desiderio esercitano il loro potere d’incantamento e senza degli occhiali critici ci si può perdere nella favola che appaga. Come scrive Rossanda per gli anni Sessanta ne La ragazza del secolo scorso, “dallo schermo milioni di persone” assorbono “meraviglie e messaggi e interpretazioni del mondo e sogni, identificazione ed evasione”.
Un libro importante dunque perché è anche una discussione sul passato che illumina lo scarso spessore della riflessione odierna sulla cultura nella sinistra, la mancanza di prospettive e interrogativi. Se cinema e politica non sono la stessa cosa, hanno però in comune per me (senza dimenticare il potere, poetico e politico, della parola scritta) la possibilità di esprimere interrogativi e dissenso verso l’ esistente e di offrire un’utopia nell’oggi, ma non bisogna lasciarsi piallare il reale e l’immaginario. Il cinema non cambia il mondo, ma quando ha spessore problematico può mutare lo sguardo e svelare il conformismo, la retorica e la mistificazione in cui siamo immersi/e.
Dopo questo libro forse riusciremo meglio a cogliere la bellezza, il fascino, il divertimento di un film senza dimenticarne la lettura politica, la considerazione del contesto in cui nasce ed è prodotto: guardare al cinema per riflettere anche sulla realtà, per capire anche le politiche, la grammatica dominante, i mutamenti in atto nella società, in un intreccio – sulla base della propria passione politica – dei piani dell’esperienza, dell’immaginario e della conoscenza.
Rossana Rossanda con Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, Il film del secolo, Bompiani overlook 2013, 341 pagine 19 euro
Catherine Clément, L’opera lirica o la disfatta delle donne, Marsilio 1979
Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso, Einaudi 2005
PUOI SEGUIRE LA SIL SU:
PASSAPAROLA:
